Della liquidità del lavoro (e se sia bene o male)
Non ci riferiamo alla dimensione economica del lavoro, considerato la primaria fonte del "cash" che ci serve per vivere, ma piuttosto alla perdita di confini rigidi dentro e fuori le organizzazioni di lavoro. Basta ruoli, tempi, spazi fisici, si può davvero fare? E, soprattutto, vale la pena di farlo?
Stefano Gheno
9/12/20243 min read
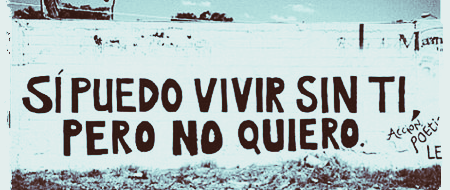
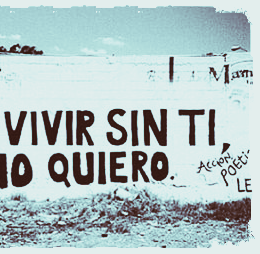
Non mi riferisco certamente alla disponibilità immediata di risorse economiche, quel “cash” di cui parlano i nuovi vati della trap, ma a quel concetto che Bauman ha introdotto per descrivere una delle caratteristiche più salienti della postmodernità e che ormai è entrato prepotentemente nel linguaggio comune: dalla società liquida al lavoro liquido il passo è breve. Vorrei quindi proporre qualche pensiero a riguardo, anche per contribuire alla discussione sulla trasformazione del lavoro nel più ampio scenario del mondo VUCA. Come di consueto proverò ad argomentare attorno ad alcuni spunti, andando poi a proporre qualche implicazione pratica degli stessi.
In generale si usa il termine “liquido” secondo un’accezione negativa. La liquidità si riferisce ad una generale perdita di certezza, che porta ad assumere una prospettiva ultimamente nichilista, totalmente centrata sul consumo immediato, nonché ad un navigare “a vista”, reattivo, nel mare della società consumistica. C’è però – a mio avviso – nella metafora della liquidità anche una possibilità positiva, legata ad una capacità di adattarsi, di infilarsi anche in spazi ristrettissimi, di essere pervasiva, di trasformare: come è noto, gutta cavat lapidem. Ovviamente faccio questa considerazione non per obiettare alla visione baumiana, ma per offrire piuttosto un possibile spazio di azione generativa anche nel tempo che attraversiamo, senza di esso la cosa più semplice sarebbe tirare i remi in barca attendendo la globale dissoluzione sociale.
La liquidità dal punto di vista della persona che lavora
Non è difficile procedere ad una prima applicazione dell’attributo liquido all’ambito del lavoro umano. Ciò a cui si assiste oggi mi pare essere una progressiva riduzione della rilevanza della dimensione del lavoro nella vita dell’uomo. Non tanto quantitativa, quanto qualitativa. L’uomo post-moderno supera le tradizionali categorizzazioni sociali otto-novecentesche: per lui il lavoro (o meglio il reddito che il lavoro produce) è frequentemente un mezzo per permettere ciò che interessa davvero, ossia il consumo. Se uniamo a ciò le circostanze attuali in cui il combinato disposto dell’emergenza pandemica con il cosiddetto reddito di cittadinanza ha non di rado indotto un’idea diffusa del poter vivere senza lavorare, magari usufruendo di compensazioni “pubbliche”, ci troviamo di fronte ad una novità circa il posto che il lavoro umano occupa nella vita. Per ricomporre questa dissoluzione identitaria la strada mi pare essere quella del lavorare sul senso, oltre che sul significato: esiste un senso "intrinseco" del lavorare, oppure è solo esogeno? Mi rendo conto che in questo periodo storico proporre un valore proprio, strutturale, non frutto di mera costruzione individuale o, al massimo, sociale può apparire un po' desueto, ma mi pare centrale per ricostruire un rapporto positivo tra l'uomo e il suo lavoro.
La liquidità nell’organizzazione di lavoro
Si dice che l’emergenza prodotta dalla pandemia abbia fatto da acceleratore circa lo sviluppo di una nuova modalità di lavoro, frequentemente definita smart, oppure con l’aggettivo italiano “agile”. In effetti ciò a cui abbiamo assistito negli anni dell’emergenza non è stato un vero e proprio smartworking, piuttosto una remotizzazione del lavoro d’ufficio. Molti dati però ci fanno ritenere che effettivamente lo smartworking avrà uno sviluppo che, per le sue caratteristiche, porterà una trasformazione importante nell’organizzazione, spostando il focus dal controllo all’autonomia dei lavoratori e aumentando, al contempo, la distanza tra identità professionale e “posto” di lavoro: non è infatti equivalente “lavorare in Fiat (tanto per dire di un azienda molto identitaria)” e “lavorare per la Fiat”. Si dovranno quindi ridefinire i modelli organizzativi, che diventano sempre più centrati sulla persona, ma al tempo stesso non potremo lasciare sola la persona di fronte alla sua esigenza intrinseca di sentirsi in relazione con altri.
Il lavoro liquido nella più ampia evoluzione sociale
Dunque andremo ad assistere (o meglio, stiamo già assistendo) ad un importante spostamento nella relazione tra l’uomo e il suo lavoro, che non potrà non avere ricadute più ampie a livello sociale accentuando – temo – la distanza tra rendita e lavoro e la diseguaglianza che comporta. Senza trascurare il fatto che l’uomo che trova la sua soddisfazione nel consumo, se impedito di consumare perché non fornito di adeguate risorse, vedrà accrescere la sua insoddisfazione con due possibili ricadute sociali: la ribellione violenta contro i privilegiati in grado di accrescere la capacità di consumo oppure l’apatia rassegnata figlia di un’impotenza appresa. C’è un rimedio a questa deriva, di cui si colgono peraltro non pochi segni? Da un lato credo risieda nella riscoperta di una certezza possibile, che poi è un altro modo per definire la speranza, dall’altro nell’evitare di porre in alternativa “liquidità” a rigidità (che è poi sempre la grande tentazione) mio post
Stefano Gheno, PsyD
Sono un consulente di vecchia data! Sarò felice di accompagnarti nelle sfide che vorrai condividere con me.
