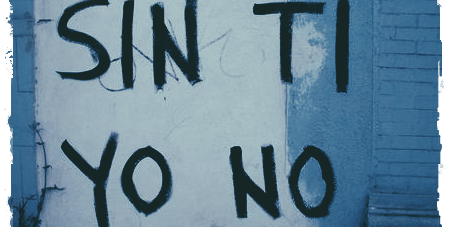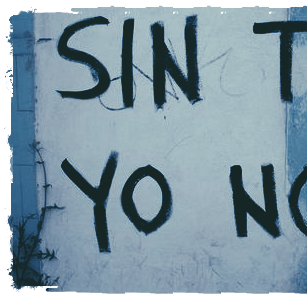Nel lavoro, la massima di Hobbes "homo homini lupus" spesso è veritiera: frequentemente le organizzazioni ci propongono un mondo di relazioni in cui il processo dominante è una competizione senza limiti, anche all’interno delle organizzazioni stesse. Tra i manager possiamo addirittura cogliere diffusamente una teoria implicita che propone la competizione come strumento per selezionare i migliori, in un darwinismo sociale elevato a modello di sviluppo aziendale.
Competizione è una parola che viene dal latino, il cui uso è decisamente molto esteso: dall'ambiente sportivo a quello politico, da quello economico a quello sociale. Tuttavia competere, in latino, stava a significare l’andare insieme verso una certa direzione, il convergere verso un medesimo punto. Dunque, la prima cosa che mi viene in mente riflettendo su questa etimologia non sono soggetti impegnati in una gara, quanto semmai in un percorso comune.
In effetti, però, gli atleti che gareggiano si dirigono tutti in una stessa direzione, ma non per andare insieme, piuttosto per ottenere una vittoria personale. E qui sta il punto: si può andare nella medesima direzione insieme, oppure indipendentemente gli uni dagli altri, magari avvantaggiandoci della sconfitta altrui.
Herbert Spencer, nella seconda metà del XIX secolo, propose una lettura dell’evoluzione sociale come lotta per la sopravvivenza: così le società evolute crescono imponendosi sulle quelle più deboli. Esisterebbe quindi una sorta di diritto naturale alla sopravvivenza solo perché si è in grado di imporsi sugli altri (e oggi - dopo quasi due secoli dall'opera di Spencer - il pensiero va immediatamente alla tragica situazione del conflitto tra Russia e Ucraina).
Spesso viene ricordato che ogni mattina una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa, così come, ogni mattina un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Non importa dunque che si sia leone o gazzella, l’importante è che si cominci a correre: solo così i più forti sopravvivono, trasferendo ai loro eredi il vantaggio della propria vittoria nella competizione della vita.
C'è anche da dire che le organizzazioni di lavoro sono necessariamente degli ambienti gerarchici: anche quelle che hanno una struttura estremamente "piatta" necessitano per il proprio governo di punti di sintesi e, pertanto, di persone che esprimano una leadership. Chiaramente ci sono modi diversi per esprimerla: spesso ricorrere alla competizione per selezionare i migliori collaboratori si accompagna all’affermazione del proprio potere da parte dei leader aziendali. Magari obbligando i propri sottoposti a dimostrazioni di fedeltà opprimendo i colleghi, considerati avversari se non nemici, o, ancora, a dimostrare il proprio valore ingaggiando battaglie all’ultimo sangue anche a detrimento del risultato collettivo.
Mi paiono fenomeni analoghi al circo dei gladiatori nell’antica Roma o ai tornei medievali: il valore, il talento si dimostrava combattendo contro i propri pari e vincendoli. Si trattava evidentemente di dinamiche profondamente simboliche, in cui era ribadita l’asimmetria del potere dell’uno sull’altro.
Inoltre le imprese si muovono tendenzialmente entro una logica di mercato. Il mercato è competitivo, e sul mercato la competizione è decisiva per permettere al consumatore o all'utente di avere il meglio al prezzo migliore. Di per sé senza una contraddizione tra interesse privato e pubblico, dato che per perseguire i propri interessi dovremmo necessariamente farci carico dell’interesse altrui.
Questo, naturalmente, se il mercato fosse in grado di regolarsi in modo autonomo e i comportamenti umani fossero sempre pienamente razionali. Oggi sappiamo che non è così, eppure il valore della competizione resta un mito diffuso.
Personalmente non credo che la competizione sia necessariamente un male: per scoprire i propri limiti, ma anche per capire fino a dove ci è possibile arrivare, può essere utile avere un confronto con qualcuno che sfidi le nostre capacità e ingaggi le nostre risorse. Tuttavia diventa certamente male quando è tesa all'annientamento dell’altro: il valore del cavaliere medioevale non risiedeva esclusivamente nella sua maestria nell’uso delle armi, ma anche nella sua condotta "cavalleresca", capace cioè di esercitare la forza, ma non la sopraffazione, nei confronti dei deboli.
Anche nelle organizzazioni c'è la possibilità di imparare dall’altro attraverso una competizione, dapprima imitandolo e proseguendo poi per un percorso che porti i soggetti al superamento dell’imitazione per un’aggiunta innovativa. Vi è tuttavia anche la possibilità dell’annientamento, qualora si cerca di primeggiare non in virtù di un valore aggiunto, ma distruggendo il valore portato dall’altro.
Nelle aziende il mito della competizione virtuosa ci pare che porti a sottovalutare, se non addirittura a negare, questa competizione viziosa, la quale al motto di "Vinca il migliore!" conduce verso diverse patologie organizzative, dal bullismo al mobbing, o al bossing. Invece la cooperazione, il fare "con" invece che "contro", talvolta risulta un concetto un po’ astratto, avulso dalla dura realtà dell’economia e del business. Eppure non c’è lista di abilità cercate dalle imprese nei loro processi di reclutamento che non riporti il teamwork, cioè la capacità di collaborare in gruppo.
Apparentemente competizione e cooperazione stanno agli antipodi, ma non sempre. Nelle imprese cooperative il conflitto tra capitale e lavoro è impedito dalla coincidenza tra di essi. Poi anche nelle coop è possibile rintracciare comportamenti organizzativi competitivi.
Probabilmente però in quei contesti la competizione individualista non risulterà particolarmente premiata, al contrario saranno premiate le condotte partecipative. Sviluppare una cultura della cooperazione, se non in alternativa, in parallelo a quella della competizione, andrà a favorire la partecipazione dei lavoratori tutti alla vita e agli obiettivi dell’organizzazione, nonché l’assunzione di responsabilità diffuse. Alimentare solo la competizione invece tenderà a provocare la deresponsabilizzazione e l’isolamento di quanti non riusciranno ad emergere.
Naturalmente tale cultura dovrà disporre di dispositivi operativi coerenti che ne evidenzino le possibilità (e le conseguenze) applicative. Nelle organizzazioni il principale tra questi dispositivi è il gruppo e la competenza che ne garantisce il buon funzionamento è la collaborazione.
Sviluppare tale competenza richiede, tra l'altro, l'esercitare la leadership in un certo modo. Il potere può infatti essere espresso secondo due direzioni opposte: riducendo i gradi di libertà altrui, si dimostra così la propria autorità facendo fare qualcosa che altrimenti gli altri non farebbero, oppure sostenendo il potere delle proprie persone, le loro competenze e responsabilità.
In azienda, i leader orientati allo sviluppo del potere dei collaboratori si propongono come coach del proprio team e attuano uno stile partecipativo e responsabilizzante. L’attenzione del leader alle relazioni orizzontali eviterà una esasperazione competitiva, dato che i dipendenti non avranno più la necessità di stabilire rapporti esclusivi con il capo, né lui avrà il problema del comando. I dipendenti saranno considerati non più solo risorse, ma compagni di strada, e attraverso la collaborazione si potrà alimentare un circolo virtuoso tra produttività e benessere dei collaboratori.