L'organizzazione come comunità di persone all'opera
E se le organizzazioni di lavoro, spesso descritte come "macchine", lo fossero davvero? Macchine sì, ma con l'anima. Macchine fatte di carne e di ossa, di sangue e sudore, di individui e di gruppi. Soprattutto macchine che dimostrano la necessaria interdipendenza di ogni uomo, confermandone così la natura intrinsecamente relazionale.
Stefano Gheno
9/2/20245 min read
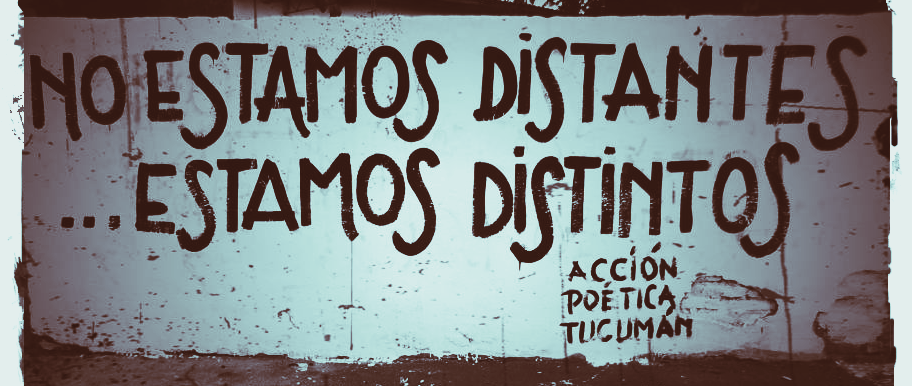
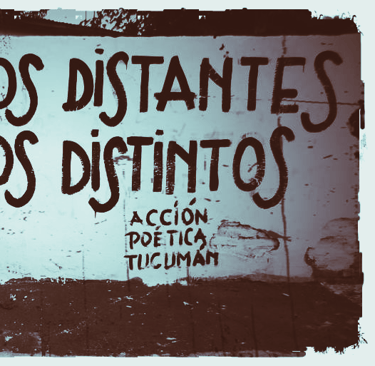
Chiunque, addetto ai lavori e profano, si è certamente confrontato con la più diffusa metafora dell’organizzazione, quella che, appunto, la descrive come una macchina. Si tratta della metafora più diffusa anche perché è facilmente comprensibile. Fornisce un’immagine chiara, semplice, che risponde bene ad una specifica esigenza di tutte le organizzazioni: dire “macchina” rimanda a produzione e risultati.
Non è strano quindi che si tratti della metafora più diffusa. Diffusa anche se molto parziale, quanto meno nel suo implicito richiamo ad un modello di razionalità assoluta, tale per cui se il disegno organizzativo è corretto l’esito del lavoro non potrà che essere quello atteso.
Sappiamo da tempo che tutta questa razionalità, in effetti, non c’è. In molti hanno dato “luce” alla parte oscura dell’organizzazione, quella “irrazionale” o, addirittura, “nevrotica”. Si tratta di contributi che portano a guardare la “macchina” organizzazione con uno sguardo nuovo: non si vede più un sistema univoco di ingranaggi che ruotano in una sola direzione e per un unico scopo, ma un sistema complesso, che può lavorare al perseguimento di obiettivi chiari e condivisi, ma allo stesso tempo andare in altre direzioni, più oscure, meno condivise, ma non per questo meno rilevanti per ciascun ingranaggio. Perché il punto è proprio questo: l’organizzazione è una macchina, ma gli ingranaggi che girano al suo interno non sono semplici pezzi di ferro, ma esseri umani.
Così definiamo l'organizzazione una "macchina con l’anima", termine quest'ultimo che possiamo considerare secondo due accezioni: quella delle anime, cioè degli individui, che la compongono (a partire dal 1600 era chiamato “stato delle anime” l’elenco delle persone che risiedevano in un luogo); quella dell’anima come principio vitale, spirito, energia che appunto “anima”, cioè muove l’agire degli esseri viventi.
É considerando quest'anima che irrompe per le organizzazioni, nell’implicita razionalità lineare dei meccanismi, la questione della soggettività, che si esprime sia a livello individuale, sia collettivo e sistemico.
A livello individuale la fede cieca verso la razionalità delle dinamiche organizzative cade sotto i colpi avversi degli errori cognitivi, euristiche e biases, che tanto influenzano i più diversi aspetti della vita nell’organizzazione: ragionamenti semplificati quando non propriamente errati incidono sull’efficacia della valutazione delle persone, degli stili di leadership praticati dai manager, fino ad arrivare a inficiare l’utilità dei sistemi incentivanti incrementando una diffusa percezione di ingiustizia, nonché delle emozioni che – a lungo negate – riappaiono prepotentemente sulla scena del comportamento organizzativo.
Le due dimensioni, la cognitiva e l’emotiva, si influenzano reciprocamente portando conseguenze non banali sia sui processi che riguardano le persone, dalla motivazione, all’apprendimento, al cambiamento, sia sui risultati del loro lavoro.
Sul fronte della della dimensione cognitiva ci è nota a rilevanza motivazionale delle convinzioni di efficacia personale: quanto più ci riteniamo in grado di agire efficacemente in un determinato ambito, tanto più ci impegneremo nel farlo e questo impegno porterà – probabilmente – a migliorare le prestazioni e i risultati che ne derivano. Anche le convinzioni circa il controllo sugli eventi di vita hanno una simile ricaduta: un locus of control interno ci porta ad approcciare agli obiettivi con maggiore senso di responsabilità, responsabilità che – in molti casi – ci permetterà di sviluppare performance più efficaci, sia a livello personale, sia collettivo.
Tutto ciò andrà poi a riverberare in qualche modo sulle dinamiche emotive, fino a collegarsi alla stima di sé, cioè al valore auto-attribuito, secondo una dinamica che possiamo ricondurre alla hegeliana dialettica servo-padrone. Si può cogliere un legame circolare tra la dimensione cognitiva della percezione della propria efficacia (io sono capace) e quella emotiva della percezione del proprio valore (io valgo), che produrrà effetti che vanno fino a modificare l’immagine di sé nel mondo.
Immagine che presto o tardi troverà la sua propria modalità di imparare, assumendo a seconda della connotazione presa una posizione attiva o passiva circa l’agire organizzativo, che potrà rendere il soggetto un protagonista della propria vita lavorativa o, al contrario, un mero esecutore di compiti attribuiti da altri. Nelle organizzazioni queste diverse possibilità si possono facilmente osservare sia che consideriamo gli esiti, sia la partecipazione.
A livello sistemico considerare la dimensione soggettiva significa innanzitutto prendere atto che nell’organizzazione agiscono processi relazionali, che legano insieme le persone, i loro ruoli, i loro compiti, le loro responsabilità e competenze.
Le relazioni organizzative non sono solo l’espressione nell’ambiente lavorativo dell’uomo, ma anche i legami tra i diversi componenti di una lavorazione. Non per niente il sogno taylorista di un ordine puramente razionale nel lavorare, reso possibile da una parcellizzazione del lavoro, si è rivelato quasi da subito e per diversi motivi un’utopia.
Per quanto possiamo scomporla, ogni lavorazione e quindi ogni prodotto o servizio che ne deriva, è l’esito dinamico di un flusso che è di più della semplice somma delle sue componenti. lo capiamo bene se pensiamo ad una corsa in bicicletta o ad una sinfonia suonata da un’orchestra: certamente il risultato è determinato dalla correttezza di ogni singola azione sul pedale o – in forma più elevata – dalla perizia dei diversi orchestrali nel suonare il proprio strumento, ma l’efficacia dell’andare in bicicletta o il gusto della performance dell’orchestra è compreso in modo decisamente più ampio, come una fusione di intenti e contributi, peraltro espressa dinamicamente, in modo che eventuali inesattezze possano essere corrette nell’emergere della coralità.
L’esempio dell’orchestra permette di comprendere anche la rilevanza dei legami nel miglioramento della prestazione individuale. Se infatti l’esito del lavoro è più della somma delle sue componenti, andrà riconsiderata la necessità di leggere l’uomo che lavora in rapporto con altri soggetti coinvolti nel lavoro stesso e non più solo in rapporto con il suo particolare compito.
Solo che la relazione è inevitabilmente faticosa e spesso tale faticosità porta a ridurne l’importanza, oppure a darla per scontato, in quanto "naturale". Nelle relazioni tra gli uomini è intrinseca una dimensione di legame e il legame, per sua natura, è faticoso: porta con sé delle reciproche obbligazioni, doveri, regole, che ci rendono dipendenti. Questo, oggi, in un contesto culturale e sociale in cui l’indipendenza è un valore conclamato risulta ancora più faticoso che in passato, quando la dimensione comunitaria era data come condizione normale dell’esistenza.
L’essere legati ad altri è faticoso, fatica da cui non di rado si vuole sfuggire e che nel lavoro e nell’organizzazione trova una espressione di particolare cogenza: perché lavorare si deve, da sempre. E nel lavoro la questione del dovere fa il paio con quella del potere, come fattori dominanti.
D’altro canto il legame non porta con sé solo fatica, ma anche potere: “l’unione fa la forza”, insieme è possibile raggiungere obiettivi non perseguibili da singoli individui, nonché è possibile aumentare il livello di protezione reciproca.
Per questo possiamo dire che essere insieme per lavorare è la natura dell’organizzazione. La nostra "macchina con l'anima" diviene così una comunità di persone all'opera. Per questo è centrale comprendere come questi particolari “ingranaggi”, che sono le persone, si incastrano l’un l’altro, anche per potere aiutare la macchina a farli girare al meglio, senza produrre eccessiva usura e utilizzando ogni possibile moltiplicatore di forze.
Stefano Gheno, PsyD
Sono un consulente di vecchia data! Sarò felice di accompagnarti nelle sfide che vorrai condividere con me.
