Per una brevissima storia del lavoro umano
Si dice che la storia sia “maestra di vita”, oggi – ahimè – risulta essere una maestra parecchio inascoltata. Ciononostante, credo sia utile avere in mente come il lavoro si sia sviluppato nelle sue diverse forme ma anche nella sua concezione durante il percorso dell’umanità, per cercare di comprendere meglio come si sia arrivati oggi a stare di fronte al lavoro umano, come persone e come organizzazioni.
sg
10/3/202412 min read
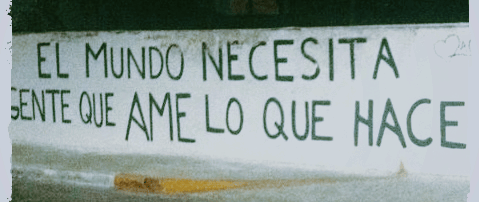
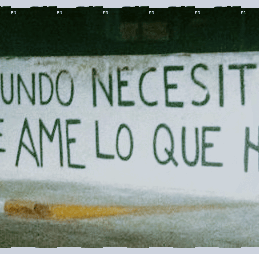
«Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, …» (Cicerone, De oratore, II, 9, 36)
Si dice che la storia sia “maestra di vita”, oggi – ahimè – risulta essere una maestra parecchio inascoltata. Ciononostante, credo sia utile avere in mente come il lavoro si sia sviluppato nelle sue diverse forme ma anche nella sua concezione durante il percorso dell’umanità, per cercare di comprendere meglio come si sia arrivati oggi a stare di fronte al lavoro umano, come persone e come organizzazioni.
La prima tappa di questa breve storia del lavoro va dalla preistoria all’antichità. Senza soffermarci troppo, anche data la “remotezza” dei tempi a cui ci riferiamo, indico tre aspetti fondamentali.
Innanzitutto, il lavoro umano è sempre esistito, poiché una qualche forma di attività organizzata, finalizzata a garantire la sopravvivenza e un certo benessere, è necessaria. Per molto tempo, questa attività si è realizzata principalmente attraverso la caccia e la raccolta dei frutti spontanei della terra. Nell’evoluzione di queste modalità, entrano in gioco diversi fattori. Il primo è che gli esseri umani iniziano a realizzare utensili, dapprima in pietra, che poi evolvono. Quella che era l’attività prevalente della caccia si trasforma in allevamento, e quella della raccolta si trasforma in agricoltura. Queste due attività, l’agricoltura e l’allevamento, continueranno a essere le principali forme di lavoro umano per molto tempo.
Un altro aspetto rilevante è che, a un certo punto della storia, appare una caratteristica tipicamente umana: la ricerca della bellezza nel lavoro. Questa bellezza non può essere descritta esclusivamente in termini utilitaristici, poiché non c’è nessun motivo utilitario che giustifichi l’abbellimento delle attività e dei manufatti. Tuttavia, questo desiderio di trovare bellezza nel lavoro accompagnerà tutta la storia dell’umanità. Anche in condizioni estreme, dove la sopravvivenza è la priorità, troviamo tempo ed energia investiti nell’estetica.
Infine, passando dalla preistoria alle civiltà antiche, abbiamo visto come il lavoro fosse principalmente un’occupazione servile. C’erano eccezioni, come il piccolo contadino o l’artigiano, ma dove c’era lavoro organizzato, la manodopera era costituita prevalentemente da schiavi. Questo vale sia per il lavoro agricolo che per quello manifatturiero. Frequentemente, anche nelle arti liberali, come il pedagogo o il medico, troviamo questa caratteristica servile. I cittadini che godevano della pienezza dei diritti, sia nella Grecia classica che nella Roma antica, si occupavano di attività non considerate lavoro, ma essenziali per l’essere cittadini: politica, religione, guerra. Queste attività erano svolte dai cittadini, non dagli schiavi.
Va detto che la schiavitù, nei tempi antichi, non aveva la cattiva fama che ha oggi: era una condizione normale della vita umana. Si poteva diventare schiavi per vari motivi, anche vendendosi per saldare i propri debiti. La prima grande rivoluzione rispetto a questa concezione del lavoro arriva con il cristianesimo e l’affermazione della cultura cristiana in Europa. Questa rivoluzione è spesso attribuita a San Benedetto, ma i primi segni di cambiamento si vedono già immediatamente dopo la nascita e la morte di Cristo.
Troviamo questo concetto sia nei Vangeli che nelle epistole di Paolo: «Non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). In una delle sue lettere, Paolo descrive il suo soggiorno presso una comunità e fa un’osservazione molto interessante. Dice: «…noi non abbiamo vissuto oziosamente fra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi come esempio da imitare. E infatti quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare neppure mangi.» (2Tes 3, 7-10).
Essendo un apostolo, Paolo aveva sicuramente un rango elevato all’interno della comunità cristiana. Tuttavia, non ha esercitato questo diritto per permettere agli altri di imparare dal suo comportamento, mostrando che nessuno deve essere di peso agli altri. Paolo, di mestiere, era tessitore e spesso viene rappresentato con il suo telaio, che portava con sé per mantenersi anche mentre svolgeva il suo apostolato.
San Benedetto, poi, ha cambiato radicalmente la prospettiva sul lavoro con il suo celebre «Ora et labora». Nell’antichità, occuparsi delle cose celesti e lavorare erano considerati due attività alternative. Peraltro, si usa il termine labor che per i latini indicava il lavoro manuale, un’attività fisica, come zappare la terra o costruire manufatti. Benedetto quindi ha messo sullo stesso piano la dimensione immateriale e quella materiale, affermando che entrambe hanno pari dignità e che, per essere perfetti, bisogna praticarle entrambe.
Questa visione non era tanto una rivoluzione ideologica, poiché – abbiamo visto – già all’inizio del cristianesimo si diceva che non ci sarebbero stati più servi né liberi, quindi né schiavi né padroni, ma tutti sarebbero stati uguali in Cristo. Tuttavia, con Benedetto, questa concezione è diventata una dinamica sociale. Non a caso, San Benedetto è uno dei patroni d’Europa. Dopo la caduta dell’Impero Romano d’occidente e le invasioni barbariche, che almeno in parte la provocarono, attorno ai monasteri benedettini è rinata una civiltà in cui il lavoro non era più prerogativa degli schiavi, ma un’attività di persone libere.
Ovviamente, la storia non funziona mai in modo binario, come un interruttore acceso o spento. In realtà, attraversiamo lunghi periodi in cui diversi sistemi di pensiero, orientamenti valoriali e idee organizzative convivono. Nel Medioevo, per esempio, la presenza degli schiavi persiste per tutto il periodo, non scompaiono dall’oggi al domani. Allo stesso modo, troviamo ancora alcune caratteristiche sociali tipiche dell’era antica, in particolare quelle in cui gli uomini liberi sono guerrieri, religiosi o prìncipi. Tuttavia, vediamo anche l’emergere di una nuova classe sociale: i lavoratori liberi. Il prototipo di questa nuova categoria sociale è l’artigiano. L’artigiano è colui che, avendo una competenza, riesce a vivere grazie a essa. Non vive perché il suo padrone gli permette di vivere in cambio del suo servizio, ma possiede delle risorse proprie. Utilizzando queste risorse e competenze, le mette in vendita e riesce a guadagnarsi da vivere. Questo passaggio è estremamente interessante perché attorno a questa nuova figura nascerà una nuova organizzazione sociale, man mano che questa figura prende il sopravvento. Se siete appassionati di questi argomenti ma non avete voglia di ritornare sui manuali di storia, i primi tre romanzi della Saga di Knightsbridge di Ken Follett sono meravigliosi per mostrare questa traiettoria. Descrivono l’epopea di un muratore nel basso medioevo, mostrando come vanno di pari passo il cambiamento nella concezione di sé come lavoratori e nella concezione sociale.
Quando iniziarono le invasioni barbariche e le popolazioni germaniche si stanziarono nell’Europa centro-meridionale, due sistemi sociali iniziarono a incontrarsi e a scontrarsi. Così facendo, iniziò un fenomeno di integrazione tra due culture che convivevano: quella romana, una cultura d’ordine basata sul diritto e organizzata attorno alla città, e quella delle tribù germaniche, una cultura di guerra e di popolazioni nomadi che vivevano di rapina e saccheggio. I Romani, ormai ricchi e stanchi, si trovarono incapaci di resistere. Iniziarono quindi ad assoldare tribù germaniche, affidando loro la difesa dell’impero. Questi popoli, una volta giunti nelle città romane, rimasero affascinati dalle infrastrutture e dal benessere romano: “Noi passiamo la vita in mezzo alla brughiera, sopra un cavallo, mangiamo carne cruda. Guarda cosa hanno questi qui: acquedotti, templi, circhi”. Dopo un po’, pensarono: “Beh, in fondo noi siamo più forti, ci hanno già dato le armi, perché non prenderci tutto?”
Così nacquero i regni romano-barbarici. Questo significa che, un po’ alla volta, i Romani iniziarono ad apprezzare alcuni elementi della cultura barbarica e viceversa. I barbari apprezzavano i Romani, soprattutto le romane, e anche i Romani iniziarono a formare famiglie con donne barbare – si sa che l’esotico attira sempre – e così facendo nacque una nuova società. Badate bene che per loro erano diventati tutti romani: “Noi siamo romani! Certo, ci chiamiamo con nomi stranieri, ma siamo romani.”
Per quanto riguarda la schiavitù, sia i Romani che i barbari la utilizzavano. Tuttavia, col passare del tempo, i Romani si erano fatti più moderati: gli schiavi, dopo alcuni anni di servizio, venivano liberati e diventavano liberti. Normalmente, il patto era che tu diventavi quasi un libero cittadino, ma dovevi gratitudine al tuo ex padrone. Le popolazioni barbariche non avevano questo principio. Di conseguenza, nelle città la schiavitù tendeva a scomparire, mentre rimaneva nelle campagne. Avete sicuramente sentito il termine “servitù della gleba”, che è un concetto già presente tra i Romani. Non era proprio schiavitù, nel senso che potevi avere delle proprietà e dei campi, ma non potevi farne ciò che volevi. Eri comunque tenuto a dare una parte al tuo signore e non potevi lasciare la terra senza il suo permesso. La servitù della gleba significa essere legati alla terra.
Quando c’era ricchezza e abbondanza, si trovava un accordo. Quando invece i signori diventavano eccessivamente avidi e tirannici, i servi scappavano. Andavano nelle città, che nel frattempo, diventando realtà economiche sempre più significative, acquisivano anche diritti, come quello di non rispondere più al signore feudale. Quindi, il servo della gleba si trasferiva in città, ma non sapeva fare nulla di utile in un contesto urbano, poiché le sue competenze agricole non servivano. Così nasce una classe di persone che si mettono al servizio di coloro che sapevano fare ciò che era necessario. È il principio delle corporazioni: inizi come apprendista, poi, se superi l’apprendistato, vieni assunto a tempo indeterminato. Questo sistema, che oggi chiamiamo stage e apprendistato, è stato inventato nel Basso Medioevo. Inizi come manovalanza, impari un mestiere e, una volta acquisita sufficiente esperienza, puoi metterti in proprio con tanto di patente, bollo e timbro. A quel punto, il tuo vecchio padrone non potrà più dirti nulla, perché sarai autonomo.
Questo processo è affascinante: a un certo punto della storia, il lavoro inizia a essere uno strumento di emancipazione, tanto che nasce una nuova classe sociale. Prima c’erano gli aristocratici e i contadini. Gli aristocratici governavano e combattevano, mentre i contadini lavoravano la terra. Sotto i contadini c’erano i servi. A un certo punto nasce la borghesia, la classe socioeconomica delle persone che vivevano in città. Queste persone erano principalmente artigiani o commercianti.
La borghesia diventa la classe sociale dominante. In Italia, i Comuni, nati già nel Medioevo, diventano libere città e inventano nuove forme di Repubblica, governate quasi sempre da corporazioni, quindi da chi lavorava. Questo fenomeno è molto interessante perché mostra come il cambiamento nella concezione del lavoro abbia impatti non solo sull’organizzazione del lavoro stesso, ma anche sull’organizzazione sociale.
A un certo punto arriva la modernità. Nei manuali di storia si indica convenzionalmente il 1492, anno in cui Cristoforo Colombo scopre l’America. L’Impero Romano d’occidente cade alla fine del V secolo d.C., quindi ci sono 1000 anni di storia tra la fine dell’antichità e l’epoca moderna. Dal punto di vista del lavoro, cosa cambia con la modernità? Sicuramente l’impatto tecnologico è la cosa più importante. Iniziano a essere sviluppate tecnologie che cambiano drasticamente il modo di lavorare. La prima e la più importante di queste tecnologie è il telaio meccanico.
Prima dell’invenzione del telaio meccanico, tessere era un’arte, non era un’attività che potesse svolgere chiunque: ci voleva una persona competente, che sapesse eseguire certe operazioni. Le corporazioni medievali erano molto brave a mantenere i “segreti dell’arte”, proprio perché chi possedeva il know-how aveva il potere. Alla fine del 1500 Bacone ci ricordava che «Scientia potentia est» (sapere è potere), ma in realtà questo concetto era agito già da prima. Le corporazioni evitavano che chi non era membro potesse conoscere i segreti dell’arte, altrimenti chiunque avrebbe potuto improvvisarsi artigiano. Il telaio meccanico, però, permise anche a persone incompetenti di realizzare tessuti, e queste persone potevano essere pagate di meno. Con l’aggiunta della macchina a vapore, si verificò la rivoluzione industriale.
Il problema non era più la competenza, ma la produzione. Con l’industrializzazione, diminuì la necessità di artigiani, mentre aumentò quella di commercianti, poiché con l’aumento delle capacità produttive servivano grandi quantità di materie prime. Le fabbriche inglesi, ad esempio, avevano bisogno di molto cotone per produrre tessuti, e le macchine dovevano funzionare continuamente. Lo stesso valeva per il carbone, necessario per alimentare le macchine a vapore.
Qui inizia un grave problema. Se in passato il lavoro era uno strumento di emancipazione, ora torna a essere una forma di servaggio. È qui che nasce il capitalismo, quando i mezzi di produzione non sono più di chi produce. L’artigiano aveva i suoi strumenti concettuali e operativi, attraverso i quali trasformava la materia e produceva reddito. Ora l’industriale possiede i mezzi di produzione, non i suoi operai, e quindi guadagna sul lavoro degli operai. Meno li paga, meglio è; più producono, meglio è.
Così nella seconda metà del XIX secolo, la situazione si era fatta piuttosto pesante. Un pensatore di cultura germanica, di nome Karl Marx, iniziò a dire: “No, ragazzi, così non va bene!”. Egli costruì un’intera teoria economica che pure, dal punto di vista economico, non funzionava perfettamente, ma come ipotesi di giustizia sociale era molto efficace. Al centro di questa teoria c’è l’idea che la storia umana sia guidata dalle condizioni materiali e dalle forze produttive. In altre parole, i cambiamenti economici e tecnologici influenzano profondamente le strutture sociali e politiche.
Marx credeva che la storia fosse caratterizzata dalla lotta tra classi sociali opposte. Nel sistema capitalistico, questa lotta è tra la borghesia, che possiede i mezzi di produzione, e il proletariato, che lavora per la borghesia. Secondo Marx, il valore di una merce è determinato dalla quantità di lavoro necessaria per produrla. Tuttavia, i lavoratori non ricevono il pieno valore del loro lavoro, poiché una parte viene appropriata dai capitalisti come profitto.
Un altro concetto chiave della teoria di Marx è l’alienazione. Egli sosteneva che i lavoratori nel sistema capitalistico sono alienati – cioè tagliati fuori, allontanati – dal prodotto del loro lavoro, dal processo produttivo, dagli altri lavoratori, ma anche dalla loro stessa essenza umana.
Questo accade perché non controllano i mezzi di produzione e il loro lavoro è ridotto a una mera merce. Così, il proletariato, sfruttato e alienato, avrebbe dovuto organizzarsi per rovesciare il sistema capitalistico attraverso una rivoluzione. Questo avrebbe portato alla creazione di una società senza classi, in cui i mezzi di produzione sarebbero stati posseduti collettivamente.
Abbastanza realistico, no? Anche perché nel frattempo non siamo più nell’antichità, un tempo in cui lo schiavo, tutto sommato, diceva “vabbè, sono schiavo, pazienza”. Siamo nell’epoca moderna. Nel frattempo, sono successe molte cose: ci sono state rivoluzioni che hanno prodotto cambiamenti drastici e ha iniziato a nascere l’idea di partecipazione popolare e democrazia. C’è stata la Rivoluzione Francese, un cambiamento politico radicale, la dichiarazione dei diritti dell’uomo, ma sul versante economico non si vede ancora nulla, serve una nuova e diversa rivoluzione.
E qui emerge il grande problema del marxismo: il lavoro, che di per sé è una cosa positiva, nella società capitalistica diventa una schiavitù. Per permettere ai lavoratori di riappropriarsi del loro lavoro, è necessario far cadere la società capitalistica. Questo rende inevitabile una nuova rivoluzione, perché capitale e lavoro sono inevitabilmente in conflitto. Non c’è possibilità di accordo: se stai dalla parte del capitale, sei contro il lavoro. Questa concezione ribalta totalmente quella del cristianesimo, che promuoveva una società armonica in cui le diverse componenti lavoravano insieme in maniera integrata, “non c’è più né schiavo né libero”, ognuno con il proprio compito e spazio. Marx dice che questo non è possibile perché l’interesse del capitalista è opposto a quello del lavoratore. Non c’è un interesse comune, quello che oggi chiameremmo il bene comune. È una guerra senza quartiere: o vinco io, o vinci tu.
Tutto ciò avviene in un contesto in cui il pensiero dominante del XIX secolo è il positivismo. Questo significa che tutte le preoccupazioni metafisiche sono tendenzialmente eliminate dalla cultura, concentrandosi esclusivamente sull’aspetto materiale della realtà. Nell’ambito della filosofia marxista, si inventa addirittura una disciplina chiamata materialismo storico, per affermare la necessità di una trasformazione nel pensiero umano. Questo non riguarda solo la politica, ma permea tutta la società. C’era una logica diffusa per cui le uniche cose che contavano erano quelle tangibili. In questo contesto, un altro personaggio importante è Charles Darwin, che affermò qualcosa che in realtà tutti sapevano già: la realtà non è sempre uguale a se stessa, ma cambia ed evolve. Questo concetto iniziò a sgretolare la filosofia conservatrice che sosteneva l’immutabilità dell’ordine costituito.
L’idea fu che ciò che aveva intuito Darwin sull’evoluzione della specie funzionasse anche in campo sociale, cioè, come si trasforma la società? Secondo questi seguaci del darwinismo, lo strumento di evoluzione sociale è il conflitto. La visione semplificata di Darwin era che vince la specie più forte; quindi, il conflitto è visto come il motore della trasformazione sociale, un concetto che si adatta perfettamente alla logica marxista. La Rivoluzione Francese, ad esempio, ha dimostrato che è possibile rovesciare i regnanti, e la Rivoluzione Americana ha portato ulteriori cambiamenti nei rapporti tra gli stati.
Questo mito del progresso positivo e l’ideale trasformativo fondato sulla rivoluzione industriale durano però poco, meno di un secolo. Paradossalmente, questi pensieri di crescita, sviluppo e libertà sono quelli che hanno dato origine a meccanismi sociali che nel XX secolo conosceremo come totalitarismi. Tutti i totalitarismi sono figli del mito del progresso, basati sull’idea che attraverso un’iniziativa violenta e conflittuale si possa cambiare l’uomo. Il nazismo si fondava sulla razza, il totalitarismo sovietico sulla classe sociale, ma l’idea comune era quella di costruire un “uomo nuovo”.
I totalitarismi eliminano la nozione di libertà del soggetto, perché la libertà è vista come una debolezza. Tu, giovane ariano o tu operaio, esisti solo in quanto funzionale al sistema. Se non appartieni a una classe o a una razza, non esisti. In Europa, abbiamo visto le conseguenze impensabili dell’applicazione di questi principi, ma si può fare anche di più. Pensiamo a Pol Pot in Cambogia, che sterminò tutti i suoi concittadini sopra i 40 anni perché troppo vecchi e quindi impossibili da “redimere”, oppure Mao, che con la sua rivoluzione culturale, internò in campi di concentramento migliaia di intellettuali perché pensavano troppo e ragionavano con la propria testa, mentre lui voleva una Cina di persone che ragionavano con la testa del partito.
Vorrei sottolineare che queste azioni nascono spesso da ottime intenzioni! Hitler voleva difendere il proprio popolo dalle minacce di popoli inferiori, Lenin e Stalin volevano difendere i lavoratori dal potere dei capitalisti, Mao voleva difendere il popolo cinese dall’arretratezza e dal colonialismo. Tuttavia, l’ideologia ha preso il sopravvento. L’ideologia è non guardare la realtà per quello che è, ma per come tu pensi dovrebbe essere.
Vi chiederete perché tutto questo ci interessa. Perché anche nelle organizzazioni di lavoro agiscono le ideologie. Quando parli di visione organizzativa, stai parlando di come dovrebbe essere una certa realtà, come quella dell’azienda. Ad esempio, se pensi che agli esseri umani il lavoro faccia schifo, allora dovrai costringerli a lavorare. Oggi non puoi più utilizzare schiavi, ma puoi schiavizzarli attraverso il denaro, così inventi il cottimo: se lavori 100 ti pago 100, se lavori 50 ti pago 50. Se il tuo collega lavora 120 e tu solo 100, ti tolgo venti. Anche se il cottimo è stato formalmente abolito, esistono ancora ambiti in cui di fatto è come se esistesse. Henry Ford, l’inventore dell’azienda moderna, prese le teorie di Taylor e le trasformò in dispositivi concreti. Ford sapeva che l’incentivazione economica era uno strumento efficace per mantenere la relazione tra azienda e lavoratore, ma si trattava di una relazione basata su un’idea di uomo quanto meno riduttiva, in cui un senso intrinseco del lavorare, il gusto di un lavoro ben fatto, non veniva considerato: “lavoro perché mi pagano”, “ti pago perché lavori (quanto e come dico io)”. E oggi, a che punto siamo?
Stefano Gheno, PsyD
Sono un consulente di vecchia data! Sarò felice di accompagnarti nelle sfide che vorrai condividere con me.
